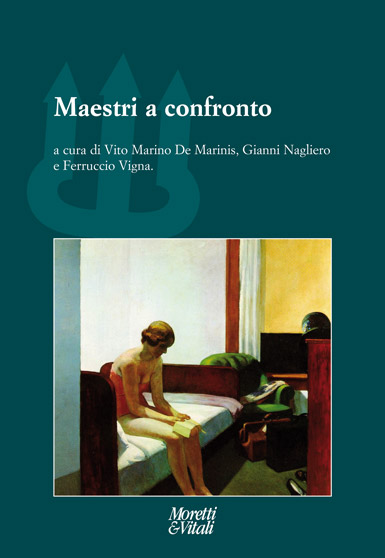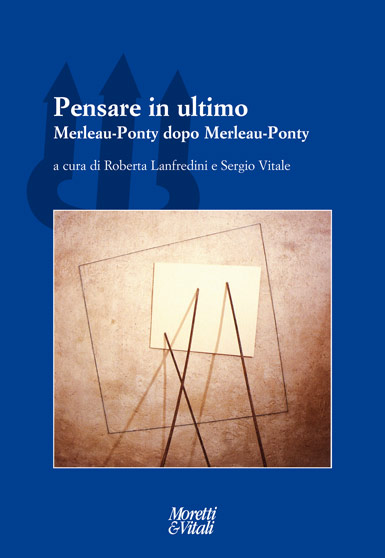In queste pagine sono raccolte le relazioni presentate nel convegno Maestri a Confronto, organizzato congiuntamente da AIPA, ARPA e CIPA a Torino il 13 ottobre 2012 in ricordo di James Hillman e Mario Trevi, recentemente scomparsi. Un convegno che rappresenta il punto di partenza dello sforzo congiunto delle tre principali associazioni junghiane italiane aderenti allo IAAP nel ricreare le condizioni per un dialogo costruttivo, che parta proprio dall’accettazione delle diversità esistenti nel panorama junghiano e le accolga come un valore aggiunto, una possibilità di molteplici letture, da punti di vista differenti, della medesima realtà. E’ questo il back ground del confronto, qui proposto, tra due maestri che hanno declinato la loro identità junghiana in modo molto diverso, restando però sempre fedeli ai valori che ci definiscono. In particolare, ambedue gli autori rimandano a un modo di essere junghiani dopo Jung: essi hanno aperto prospettive nuove e significative, sviluppando aspetti parziali del complesso e a volte contraddittorio corpus teorico del Maestro. Ambedue hanno cercato, pur in modi diversi, di traghettare il pensiero junghiano nel terzo millennio, rimodulando gli aspetti che fanno di Jung un pensatore del Novecento. Hillman e Trevi parlano all’uomo post-moderno, un uomo cioè che ha perso fiducia in ogni verità assoluta, ed è costretto a convivere con verità parziali, contestuali. A fronte di questo panorama, entrambi gli autori si propongono, con modalità differenti, di liberare il pensiero di Jung dai suoi aspetti metafisici e positivistici. Ambedue rimangono, però, profondamente junghiani nel loro essere fedeli alla propria realtà intima, individuale, e aderenti a una precisa idea di libertà: libertà di pensare pensieri nuovi, al di là delle convenienze personali, delle convenzioni collettive, di ogni dimensione scolastica e di ogni irrigidimento identitario.
I saggi che compongono questo libro dedicato al pensiero di Maurice Merleau-Ponty muovono tutti dalla convinzione, espressa dallo stesso Merleau-Ponty, secondo cui c’è sempre un impensato che ogni filosofo si lascia alle spalle quando giunge al termine della propria vita, che appartiene a lui solo interamente, ma che nel contempo mette capo a qualcosa o a qualcun altro. Ciascun pensatore, in altre parole, circoscrive con la propria opera, attraverso gli aspetti frontali e manifesti della sua parola, un campo che è ancora da meditare, lasciando ad altri il compito di attraversarlo e di ampliarlo, di modo che la fedeltà alle proprie idee possa essere affermata nella maniera più autentica se non pensando di nuovo. Questo è quanto gli autori del presente volume si sono proposti di fare, mirando ad alcuni temi della filosofia di Merleau-Ponty che appartengono alla fase finale di un’esistenza prematuramente interrotta o che, per quanto vivi e operanti, sono però rimasti allo stato latente oppure confinati in manoscritti che solo di recente sono stati resi di dominio pubblico, costituendo quell’ombra che accompagna sempre le figure dei grandi filosofi, e in cui spesso risiede il loro lascito più fecondo e duraturo. Emerge così la ricchezza e la vitalità di un pensiero ben lontano dall’aver esaurito la profondità della propria portata e che continuerà a fecondare la ricerca filosofica ancora per molto tempo a venire.