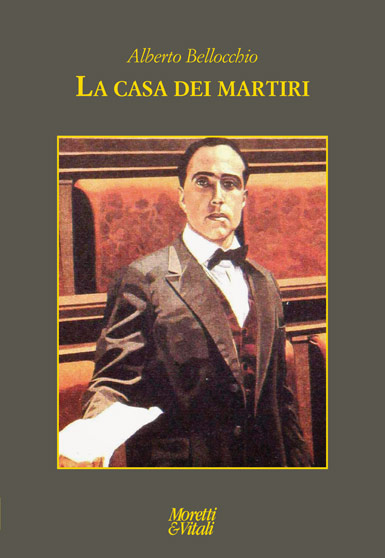Il testo, affrontando l’intreccio dei linguaggi, non certo con la pretesa di scioglierne tutti i nodi, ma soltanto di migliorarne un poco la comprensione reciproca tra le molte torri, ruderi di torri e abbozzi di torri cui si è divisa la psicologia e la psicoterapia, si propone di esporre e confrontare da un lato le tecniche, con le loro conseguenze sulla teoria ed il linguaggio usato, dall’altro le radici (dovute a precedenti opere costruttive), che in tali tecniche e teorie si sono fuse, rimescolandosi inestricabilmente.
Il contributo di Paola Sabia esplora, rivelando tra l’altro molte informazioni ignote alla maggioranza degli psicodrammatisti, le radici del creatore del modello dello psicodramma classico. Luciana Silvestri e Melania Barbarello mostrano come le diverse matrici professionali e culturali di quattro psicodrammatisti, Navarro, Henche, Blobel, Brem, si siano intrecciate con i loro metodi di lavoro. Nel contributo di Alessandra Verri è centrale, nell’esporre il pensiero e l’opera di Anne Ancelin Schützemberger, la descrizione delle origini e dello sviluppo dello Psicodramma triadico. Rossella Della Pepa confronta, scegliendo come punto focale la modalità con cui affrontano il lavoro sul sogno, differenti scuole di psicoterapia, a partire dal loro modo di operare. Emanuela Gagliostro ha preso in esame l’applicazione del modello psicodrammatico nei setting di psicoterapia duale. Il contributo di Enzo Bellia prende spunto da un confronto tra i modelli della DanzaMovimentoTerapia e dallo Psicodramma Analitico. Infine Claudio Giacobbe, riportandosi ad un’altra fondamentale matrice del nostro modello di psicodramma, il pensiero junghiano, ci mostra come, all’interno di questo pensiero, uno stesso sogno possa venir trattato in maniera del tutto differente, a seconda della tipologia psicologica dell’analista, del suo orientamento nell’indirizzare il processo analitico e nell’uso in esso dei sogni.
In tutti questi contributi lo psicodrammatista, lo psicoterapeuta e il ricercatore, viene presentato, da un lato, con la complessa e contraddittoria matrice, costituita da molteplici linguaggi, di cui si è trovato ad essere punto focale; dall’altro, nel suo operare attraverso la pratica, come contribuisca a creare nuovi linguaggi.