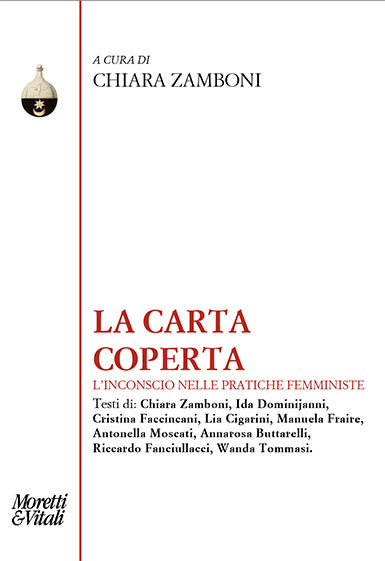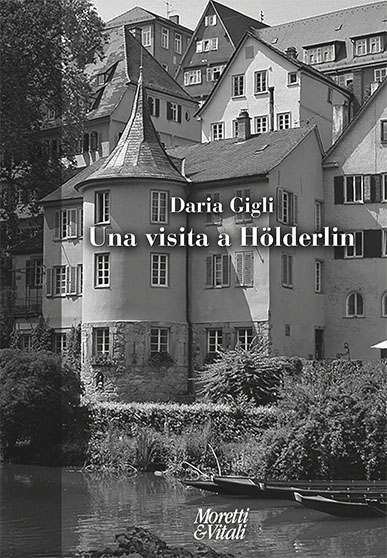Questo libro tratta del rapporto controverso tra femminismo e psicoanalisi a partire dalla concezione dell’inconscio. L’inconscio è la “carta coperta” delle pratiche di donne, e ne indica impreviste capacità di trasformazione. Il femminismo degli anni Settanta, prendendo le distanze dall’oppressione patriarcale, cercava forme inventive attingendo con molta libertà dalla psicoanalisi, ritraducendola in alcune pratiche. Nel nostro tempo, in cui la presenza femminile pubblica è molto diffusa e vediamo nuovi movimenti di donne, bisogna sostenere la necessità dell’ascolto dell’inconscio. Le tecnologie adoperate per il dominio sulla vita umana pongono una domanda inquietante: ci stiamo avviando verso un mondo senza inconscio? Questa domanda tocca particolarmente le donne, il cui corpo è ancora oggetto di manipolazione.
In questo libro si testimonia anche la preoccupazione che riguarda le sorti della differenza femminile, la cui presenza pubblica può essere cancellata se non si rilancia la pratica dell’autocoscienza e non si fa più ricerca sui processi inconsci che ci attraversano. Si rischia di scivolare di nuovo verso un mondo fagocitato dalla finzione del neutro maschile.
Chiara Zamboni insegna Filosofia teoretica all’Università di Verona. Da più anni si occupa di pensiero femminile e ha dato vita con altre alla comunità filosofica “Diotima”. Tra le sue pubblicazioni: Parole non consumate. Donne e uomini nel linguaggio (Liguori 2001), Pensare in presenza. Conversazioni, luoghi, improvvisazioni (Liguori 2009). L’inconscio può pensare? Tra filosofia e psicoanalisi (Moretti&Vitali 2013), Una filosofia femminista. In dialogo con Françoise Dolto (Manni 2015). Ha collaborato ai diversi volumi di Diotima, pubblicati dal 1987 a oggi. Da anni collabora con il Master di Duoda (Università di Barcellona).