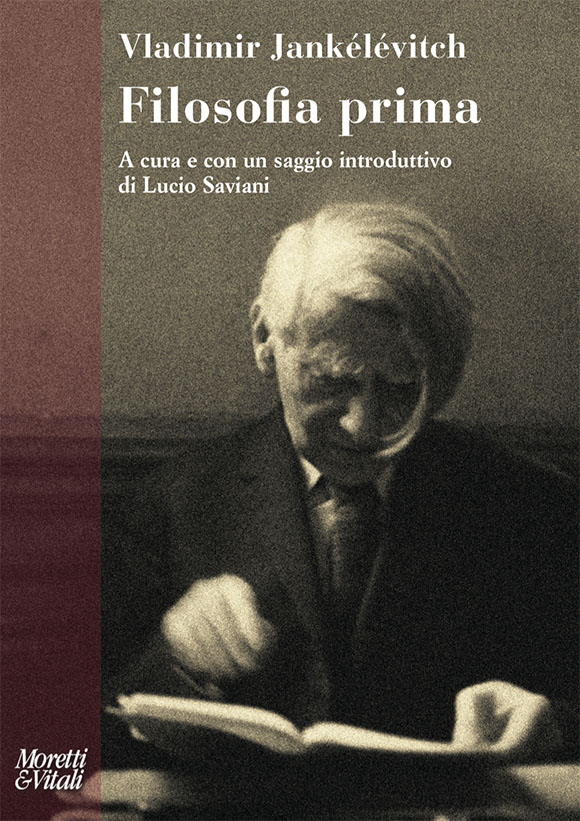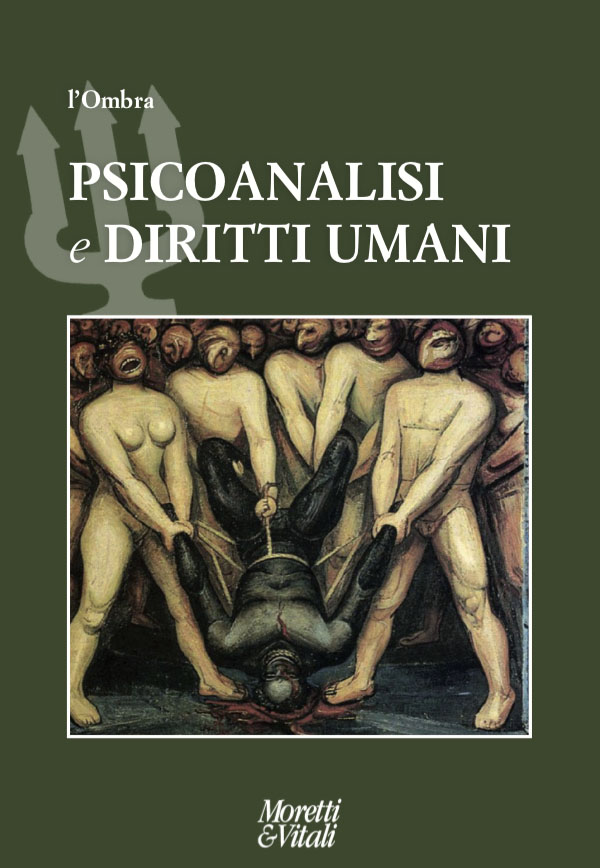Vladimir Jankélévitch
Vladimir Jankélévitch
Pubblicato nel 1954, Philosophie première viene qui tradotto per la prima volta in italiano. È l’opera più complessa, di maggiore intensità speculativa, attraversata da una tensione teoretica decisiva all’interno del percorso filosofico di Vladimir Jankélévitch. “La mia metafisica”, come lo stesso Jankélévitch ebbe a definirla.
Nel peculiare stile di “scrittura filosofica” – contaminazioni, annunci sospesi e accostamenti spiazzanti, veloci incursioni e ricorrenti riprese, neologismi, associazioni improvvise, sorprendenti arcaismi – Jankélévitch ci rimanda al VII libro della Repubblica, in cui la conversione, più che mutamento di posizione, appare come radicale cambiamento di condizione.
Un camminare in senso inverso rispetto ai “falsi metafisici”, che parlano del fondo dell’essere come se facesse parte del nostro mondo, facendone cioè una sostanza: è il percorso che attraversa da parte a parte Filosofia prima. Pensare l’incomparabile mantenendolo impensabile, ossia senza renderlo sostanza. Il compito della “metafisica seria” è pensare il mistero, ovvero l’incommensurabile. Senza camuffare il mistero, il filodosso convertito alla filosofia deve esercitarsi a mantenersi nell’incertezza. Deve sapere di non sapere (nescio quid).