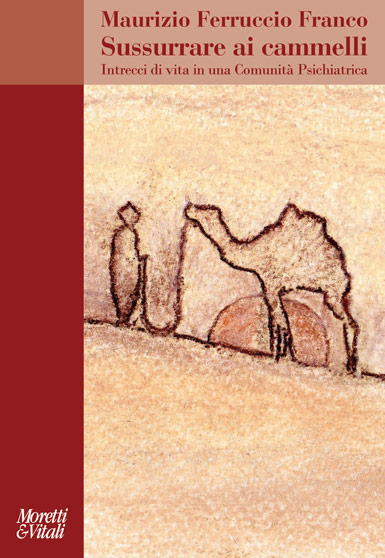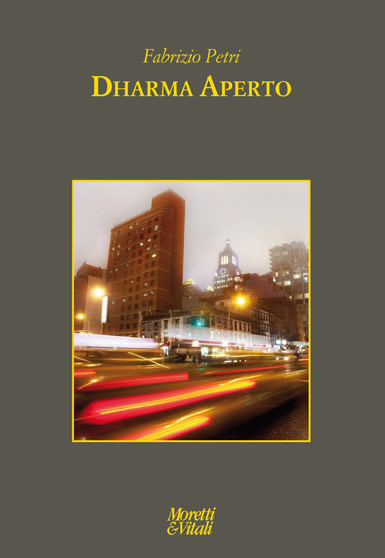Maurizio Ferruccio Franco
Maurizio Ferruccio Franco
Sono attratto dalle crepe nel muro, dalle sconnessioni dell’asfalto. Mi sorprende la vita che vi germina, mi appassiona la strada silenziosa che una radice ostinata si apre nel buio del cemento fino a spaccarlo, emergendo alla luce. Amo gli umili fiori del marciapiede che resistono alla suola delle scarpe, alla pioggia e alla calura. Vite tenaci e inconsapevoli, forse tanto più tenaci, quanto più inconsapevoli. Non ho vissuto le mura del manicomio, il loro potere di segregazione. Per fare lo psichiatra ho scelto le mura di una comunità che al manicomio resta più vicina solo per il fatto di convivere con la psicosi giorno e notte. So dell’inesorabile proprietà corrosiva di uno sguardo che si è fatto estraneo, che sulla realtà stende una patina opaca e sporca. Conosco la forza quieta della cronicità che sbriciola le architetture più solide. Mi occupo di malattie che ancora non so chiamare malattie. Di certo la nostra normalità non è così normale.
La poesia non è uno zuccherino per addolcire la follia, forse è solo un modo più efficace di descriverla condividendone il linguaggio. Risponde all’urgenza insensata del dire, dà sfogo all’oscuro ruminare di un sogno, di un grumo di parole che devono esser dette per poter tornare finalmente a dormire.