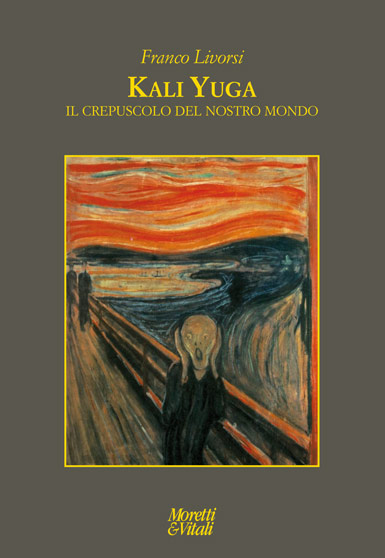Kali Yuga. Il crepuscolo del nostro mondo è un romanzo di idee e di azione. Le idee sono quelle di rinascita psicologica, spirituale e morale, ecologica e sociale, democratica e federalista internazionale, che per l’autore costituiscono l’alternativa “sistemica” alle catastrofi incombenti.
L’azione ruota attorno a due opposte, ma negative o inadeguate tendenze, immaginate dominanti nel mondo a venire, tra cinquant’anni, qualora le cose seguitassero come oggi, peggiorando a poco a poco. Da un lato potrebbe emergere un mondo neototalitario nazista, schiavista e anticristiano in nome di un “nuovo ordine”, qui immaginato prevalente, tra mezzo secolo, dall’Austria alla Cina; dall’altro un mondo democratico, sempre incentrato sull’America, diventato però via via più cinico e amorale. La conclusione sarebbe da stadio finale del “Kali Yuga”, che nell’induismo è “l’età di Kalì”, la grande dea della distruzione. Sarebbe, insomma, una catastrofe senza pari.
Dialoghi vivaci e azioni drammatiche connotano tutta la vicenda, che ruota attorno al nuovo totalitarismo di Hitler II e al democraticismo senza scrupoli di Sam Douglas, ai quali si contrappone l’ecologismo politico e spirituale di Tom Douglas (fratello di Sam), portatore di un’alternativa democratica e pacifica possibile, ma che potrebbe anche essere sconfitta se la “Storia” non dovesse via via farla propria.