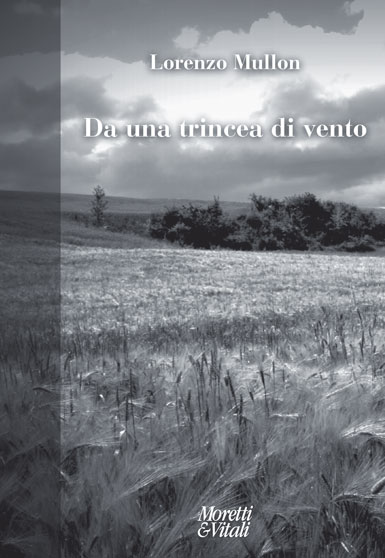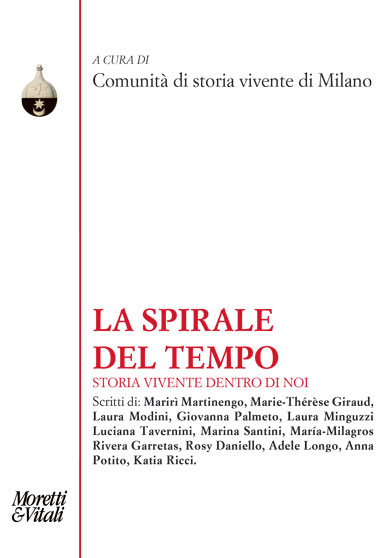Fra le piazze, le vie e gli incroci, sempre più gremiti, della poesia, tra i flussi e riflussi delle migliaia di uomini che si volgono oggi all’esercizio dei versi come a un’ultima spiaggia, Lorenzo Mullon si muove con la grazia di un danzatore, la forza d’un guerriero e la leggerezza di un funambolo. Da anni egli trascrive i suoi versi su dei foglietti sparsi o su degli smilzi fascicoletti e li offre ai passanti, ai frequentatori di parchi, a chiunque incontri mentre vaga tra Venezia (dove abita) e Milano.
Benché privi di ogni alone da “poeta laureato”, lontani mille miglia dal gusto dell’invenzione inusitata, rarefatta o preziosa, i suoi testi non sono certo opera di un naïf: la voce che in essi parla ha un timbro schietto e umano ma per nulla propenso alla retorica del genuino, al rito dei sentimenti facili, popolari. Nella sua apparente semplicità si annidano semi di una verità da scoprire lentamente, scintille di una bellezza segreta, profonda.
Da una trincea di vento è la sua prima raccolta “ufficiale”. Percorrendola in lungo e in largo i lettori saranno colpiti dalla forza sapiente di questi versi, di queste immagini in continuo movimento, degne di un maestro taoista.
Il punto ideale d’approdo dell’opera di Mullon è un inno delicatissimo e forte alla leggerezza. Sentirsi leggeri significa per lui, anzitutto, comprendere che “grande” e “piccolo” come “semplice” e “complesso”, e perfino “male” e “bene”, sono soltanto parole con cui cerchiamo di possedere l’inafferrabile: il vento dello spirito che percorre senza tregua noi e il mondo. Se ci arrendiamo al vento, e arrendendoci ci svuotiamo del peso delle idee unilaterali e capziose, la nostra visione delle cose si dilata immensamente. Mentre possiamo finalmente riconoscere che “nulla di nostro / è nostro veramente / tranne / un filo di voce / e una radice / nel mare”, riusciamo anche a sentire le voci che “abitano sotto le pietre / si nascondono / dietro le nuvole” o dimorano “nel silenzio dei boschi / nelle acque ferme / della laguna”; mentre ci è concesso capire che nessuno di noi è meglio di un mendicante (non siamo forse arrivati su questa terra nudi, privi di tutto?), in modo altrettanto chiaro ci si rivela la nostra fantastica ricchezza, il nocciolo sacro, immortale del nostro essere, quel quid irriducibile alle miserie storiche che ci colloca altrove, che fa di ognuno di noi, potenzialmente, un dio: “è il nostro respiro a muovere il vento / siamo noi a far tremolare le stelle…”